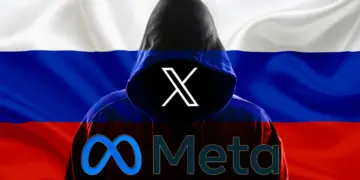Lo scorso 25 marzo 2025 si è tenuto presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati un interessante simposio dal titolo “Incontri strategici Italia e Francia”, organizzato congiuntamente da Limes e La Vigie. Riassumiamo qui alcune delle riflessioni emerse a valle della discussione.
La fine della “sicurezza delegata”
Il sipario sembra ormai calato su un’epoca. Le confortanti certezze che avevano cullato l’Europa all’indomani della Guerra Fredda, nutrendo l’illusione di una “fine della storia” e di una pace garantita da strutture internazionali apparentemente inscalfibili, si sono sgretolate sotto i colpi di una realtà geopolitica nuovamente incandescente. Il ritorno prepotente del conflitto bellico (su vasta scala) nel cuore del continente ed i recenti sviluppi all’indomani del secondo insediamento di Trump a Capitol Hill non rappresenta soltanto una tragedia umanitaria, ma diventa oggi catalizzatore di una presa di coscienza collettiva, dolorosa quanto necessaria: l’Europa si ritrova strategicamente spiazzata, costretta a confrontarsi con il venir meno di garanzie securitarie a lungo date per scontate e con il peso irrisolto della propria complessa eredità storica.
Per decenni, almeno tre generazioni di europei hanno vissuto all’ombra di un paradigma securitario fondato su una delega implicita, ancorché mai formalizzata in termini assoluti, agli Stati Uniti. La convinzione diffusa era che la guerra fosse un fenomeno esogeno, relegato a teatri lontani, o al più un onere di cui Washington si sarebbe fatta carico in nome della stabilità dell’ordine liberale. L’ombrello protettivo americano era considerato come una costante pressoché immutabile, una garanzia esistenziale contro le minacce esterne.
Tuttavia, guardando la situazione con più realismo, si scopre che questa idea si basava su principi meno solidi di quanto si creda. Anche durante la Guerra Fredda, quando il mondo era diviso in due blocchi, la protezione offerta dagli Stati Uniti aveva dei limiti che non venivano dichiarati pubblicamente. Nei piani militari reali, lontani dai discorsi ufficiali, gli americani prevedevano di poter ritardare il loro intervento o di non impiegare tutte le loro forze in caso di attacchi su larga scala contro l’Europa (così come d’altronde è stato per le due guerre mondiali).
A differenza del passato, però, emerge oggi con nettezza una ricalibrazione strategica da parte di Washington, interpretabile non come un tentativo di ripiegamento, ma come una volontaria abdicazione alla funzione di garante ultimo della sicurezza europea tout court. L’origine di questa trasformazione è complessa: vi concorre una crescente “stanchezza strategica”, un disincanto verso alleati percepiti come inclini al free riding securitario, e una ridefinizione degli interessi vitali americani, sempre più orientati verso l’Indo-Pacifico e le proprie dinamiche interne. L’Europa non appare più, agli occhi di Washington, quella risorsa strategica inestimabile da difendere a qualsiasi costo, men che meno ipotecando risorse umane e materiali ritenuti necessari altrove. Questo progressivo disimpegno, alimentato anche da una sempre più evidente distanza strategica tra America ed Europa, lascia il Vecchio Continente esposto a un ambiente internazionale più instabile, frammentato e potenzialmente ostile rispetto al passato. L’era della sicurezza delegata e incondizionata è definitivamente tramontata.
Il fardello della storia: eredità imperiali e identità contesa
Un nodo gordiano per l’Europa contemporanea risiede nella difficoltà intrinseca di conciliare la propria autopercezione con il ruolo reale che essa ricopre nell’attuale scacchiere globale. È difficile infatti scalfire la tendenza degli europei a leggere il presente attraverso le lenti deformanti della passata grandezza, rendendo ancor più ardua l’accettazione dell’inevitabile ridimensionamento della centralità del Vecchio Continente negli equilibri mondiali.
Questa dissonanza tra “immagine di sé” e realtà oggettiva affonda le radici nella profondità della storia continentale. Un dato spesso eluso nell’autoanalisi europea è la sua natura intrinsecamente post-imperiale. La quasi totalità delle nazioni che compongono il mosaico europeo sono, a diverso titolo e con diverse temporalità, ex potenze imperiali o coloniali. Questo passato, frequentemente rimosso, edulcorato o confinato a dibattiti accademici specialistici, continua a plasmare in modo determinante la percezione che attori esterni, in particolare quelli appartenenti al cosiddetto “Sud Globale” hanno dell’Europa. Agli occhi di vaste aree del pianeta, le nazioni europee rimangono primariamente identificate con il loro passato egemonico, alimentando un sostrato di risentimento storico che non manca di influenzare le alleanze, le diffidenze e le dinamiche di potere contemporanee.
Questa eredità produce una duplice distorsione: da un lato, ostacola la capacità degli europei di “prendere la misura” di sé stessi nel presente, ancorandoli a rappresentazioni obsolete; dall’altro, alimenta l’ostilità o quantomeno la cautela di nuovi attori internazionali emergenti che rivendicano un ordine mondiale multipolare, libero da egemonie occidentali.
All’interno della stessa Europa, inoltre, persistono significative fratture legate alla memoria storica. Si può tracciare una linea di faglia, simbolicamente rappresentabile lungo l’antico limes dell’Elba, che separa un Occidente europeo, a lungo protetto dalla deterrenza americana e dalla prosperità economica, tendenzialmente incline a relativizzare o “dimenticare” le asprezze della storia e le logiche di potenza, da un Oriente europeo dove le ferite storiche, le dispute territoriali e le antiche rivalità rimangono carne viva, pronte a riaccendersi. Esempi emblematici sono la persistenza di conflitti memoriali irrisolti, come quello tra Svezia e Russia attorno alla battaglia di Poltava, o, in modo ben più tragico, l’attuale guerra in Ucraina, interpretabile come l’ennesimo, sanguinoso capitolo di una secolare dialettica tra aspirazioni nazionali ucraine e logiche imperiali russe.
In questo contesto, acquista particolare rilievo anche la distinzione concettuale tra “europeo” e “occidentale”. L’appartenenza geografica al continente non implica automaticamente l’adesione piena all’insieme di valori, istituzioni e traiettorie storiche che definiscono l’Occidente. Nazioni come l’Italia e la Francia, al contrario, si collocano saldamente all’interno di questa tradizione, definite primariamente “occidentali” e solo successivamente “europee”, a sottolineare una comunanza profonda che, pur non annullando le specificità nazionali, ne costituisce un tratto identitario fondamentale.
Risentimenti globali e fratture occidentali
L’Europa si trova oggi stretta in una morsa politica e psicologica, soggetta a una duplice pressione. Da un lato, il risentimento post-coloniale proveniente da aree del Sud Globale, che si manifesta in una crescente assertività politica ed economica e nel rifiuto di logiche neocoloniali o di “lezioni di democrazia” impartite da ex dominatori. Dall’altro, l’insofferenza americana, più recente ma non meno incisiva, scaturita dalla percezione di un’Europa strategicamente immatura, economicamente concorrente ma militarmente dipendente, restia ad assumersi la propria quota di responsabilità per la sicurezza collettiva.
A rendere il quadro ancor più precario contribuisce la profonda crisi identitaria che attraversa gli stessi Stati Uniti. La polarizzazione politica esasperata, le acute tensioni sociali e razziali, il dibattito sulla stessa essenza della nazione (di cui l’ascesa di figure come Donald Trump è sintomo più che causa) e le proiezioni demografiche che prefigurano un futuro a maggioranza “non-bianca” stanno erodendo la coesione interna della superpotenza. Un’America lacerata, in cui fazioni contrapposte si percepiscono reciprocamente come minacce esistenziali, fatica a proiettare un’immagine coerente e affidabile sulla scena internazionale, rendendo così la sua politica estera più volatile e meno prevedibile. Questo sfaldamento interno, sommato alle tensioni transatlantiche, mette in discussione la stessa solidità e l’operatività del concetto di “Occidente” come blocco strategico coeso.
In tale scenario di fluidità e incertezza, l’imperativo categorico per l’Europa, e in particolare per i suoi attori principali come Italia e Francia, diventa una radicale revisione del proprio approccio strategico, improntata a un lucido realismo e a una rinnovata autoconsapevolezza. Occorre, in primo luogo, “prendere la misura di sé stessi”, valutando la propria posizione non solo attraverso il filtro dell’autopercezione, ma soprattutto considerando come si è percepiti dagli altri attori globali. In secondo luogo, poi, evitare un approccio assolutizzante, che tende a focalizzarsi esclusivamente sulla misurazione delle proprie capacità materiali ignorando le dinamiche intersoggettive e le percezioni altrui, un approccio talvolta riscontrabile in certa cultura strategica americana e oggi inadeguato in un mondo multipolare e interconnesso.
L’epoca delle alleanze monolitiche, cementate da una rigida contrapposizione ideologica, sembra cedere il passo a un’era caratterizzata da allineamenti transazionali e geometrie variabili. Le nazioni tenderanno sempre più a formare coalizioni ad hoc, basate su convergenze di interessi specifiche e contingenti, potendo collaborare con un partner tradizionale su un dossier e trovarsi su posizioni divergenti o persino allineate con un avversario su un altro. Questo scenario richiede pertanto una capacità di analisi diplomatica e strategica estremamente flessibile e sofisticata, capace di navigare la complessità senza ancorarsi a schemi precostituiti.
L’asse italo-francese alla prova
All’interno di questo quadro generale, l’asse italo-francese assume un rilievo particolare. Nonostante le cicliche frizioni politiche e le differenze di approccio su alcuni dossier, Italia e Francia condividono vulnerabilità strutturali e interessi vitali che rendono la loro cooperazione non solo auspicabile, ma strategicamente necessaria.
Un’area cruciale di convergenza è rappresentata dallo spazio “medio-oceanico”, quel continuum geostrategico che collega il Mediterraneo all’Indo-Pacifico attraverso choke points vitali come Suez e Bab el-Mandeb. La sicurezza e la libertà di navigazione in queste arterie marittime sono essenziali per le economie di entrambi i paesi, sebbene con accentuazioni diverse. L’Italia, per la sua configurazione geografica di penisola protesa “nello stretto”, dipende in modo quasi esistenziale da queste rotte. La Francia, pur godendo di un affaccio oceanico diretto e di una proiezione globale grazie ai suoi territori d’oltremare (la France d’outre-mer), non può prescindere dalla stabilità di quest’area per i propri interessi economici e strategici. La presenza navale e le operazioni congiunte in zone come il Mar Rosso testimoniano efficacemente la consapevolezza di questa interdipendenza.
Un secondo teatro di interesse comune, spesso sottovalutato, sono i Balcani. Lungi dall’essere un’area pacificata, la regione rimane un mosaico instabile, caratterizzato dalla fragilità di entità statuali post-jugoslave (definite provocatoriamente “stati finti” per sottolinearne la precaria sovranità effettiva), dalla pervasività di economie illegali e dall’influenza crescente di potenze esterne, tra cui spicca la Turchia, attore regionale con ambizioni neo-ottomane che ha saputo costruire una significativa area di influenza culturale, economica e politica. La prossimità geografica e il potenziale di contagio delle crisi balcaniche impongono a Roma e Parigi un impegno coordinato e costante per la stabilizzazione, la prevenzione dei conflitti e il contrasto alle attività illecite.
Istituzioni svuotate e sfida valoriale
L’analisi non può esimersi da una riflessione critica sullo stato di salute delle grandi istituzioni occidentali, NATO e Unione Europea in primis. Concepite e sviluppate nel contesto della Guerra Fredda, spesso sotto l’impulso determinante degli Stati Uniti, queste architetture istituzionali appaiono oggi afflitte da una crescente autoreferenzialità. Esse rischiano di operare per inerzia burocratica, disancorate da un reale consenso profondo sui valori fondanti o da una visione strategica realmente condivisa tra i loro membri. Il pericolo concreto è che diventino gusci vuoti, formalmente esistenti ma strategicamente inefficaci, nel momento in cui viene meno il collante culturale e valoriale che ne costituiva l’anima originaria.
Le regole del gioco – quel complesso di norme non scritte, consuetudini e presupposti culturali che precedono e plasmano le istituzioni formali – sembrano oggi messe in discussione all’interno dello stesso campo occidentale. Se l’Occidente smarrisce la consapevolezza della propria identità storica e valoriale, se la “misura comune” si dissolve in un relativismo paralizzante o in una polarizzazione distruttiva, le istituzioni, pur sopravvivendo sulla carta, perderanno inevitabilmente la loro legittimità intrinseca e la loro capacità propulsiva.
In questo senso, un’azione concertata italo-francese assume importanza anche nel dialogo con Washington. Non si tratta di rivendicare nostalgicamente un passato irripetibile o di mendicare protezione, ma di riaffermare con fermezza, agli interlocutori americani e a sé stessi, l’esistenza di un patrimonio valoriale comune – incentrato sulla libertà, sullo stato di diritto, sulla dignità della persona – che, pur necessitando di essere reinterpretato alla luce delle sfide contemporanee, rimane l’unico possibile fondamento per un’azione collettiva significativa dell’Occidente nel XXI secolo.
Conclusione: l’imperativo del realismo europeo
Il panorama geopolitico attuale impone all’Europa un esercizio di lucidità e realismo scevro da autoindulgenze. Il crepuscolo delle illusioni post-storiche, la ricalibrazione della postura americana, il peso delle eredità irrisolte, le fratture interne al campo occidentale e l’emergere di nuovi poli di potere globali delineano uno scenario complesso e irto di sfide. Per le nazioni europee, e in particolare per attori chiave come Italia e Francia, ciò si traduce nella necessità impellente di ridefinire la propria collocazione strategica.
Questo implica, innanzitutto, acquisire una piena consapevolezza dei propri limiti e delle proprie vulnerabilità, abbandonando narrazioni autocelebrative anacronistiche. Comporta, inoltre, il riconoscimento della crescente natura transazionale delle relazioni internazionali, che richiede pragmatismo e flessibilità nell’identificare convergenze di interessi. Esige un’analisi rigorosa delle aree geografiche e funzionali (come lo spazio medio-oceanico e i Balcani) dove la cooperazione bilaterale ed europea non è un’opzione, ma una necessità dettata dalla geografia e dalla storia. Impone, infine, di non recidere il legame transatlantico, ma di rifondarlo su basi più mature ed equilibrate, riaffermando l’importanza di un nucleo di valori condivisi come bussola indispensabile per navigare le acque agitate del nuovo disordine mondiale. Il dialogo e la cooperazione strutturata tra Roma e Parigi, pur tra inevitabili difficoltà, rappresentano un tassello fondamentale in questo arduo ma ineludibile percorso verso una maggiore responsabilità e autonomia strategica europea.