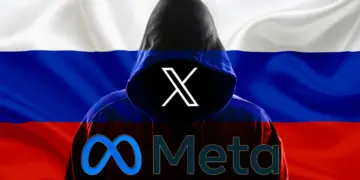Caratteristiche, scopi e tattiche per la disinformazione
La disinformazione online è una pratica sempre più comune nei contesti della guerra informativa, che si esplica nella diffusione deliberata e sistematica di informazioni false, fuorvianti o distorte con l’intento di influenzare le percezioni, le decisioni e i comportamenti di un pubblico target. Il fenomeno è in evoluzione e si arricchisce continuamente grazie all’innovazione tecnologica, ma mantiene essenzialmente delle immutate caratteristiche di base.
Primariamente, va considerato che non è importante che l’oggetto della disinformazione sia una notizia reale o irreale, verosimile o inverosimile, una notizia rimaneggiata o ben descritta.
L’oggetto di disinformazione può essere settoriale o monotematico ma deve incidentalmente coinvolgere altri temi anche generici e prestarsi ad un certo numero di interpretazioni. Necessita, inoltre, di una storia che consenta di presentare la disinformazione in modo funzionale all’interesse politico perseguito. Ad esempio, se si vuole alimentare l’odio verso qualcuno, vanno sempre coinvolti elementi che portino il fruitore della notizia ad identificare immediatamente la persona o il gruppo contro i quali si vuole stimolare un sentimento di ostilità.
L’obiettivo finale di una campagna di disinformazione online di tipo moderno non è quello di creare del convincimento circa una falsa narrazione della realtà, ma è piuttosto quello di stimolare la polarizzazione delle opinioni mobilitando frange specifiche delle opinioni pubbliche. La polarizzazione online è un fenomeno estremo che si verifica all’interno degli ambienti digitali in cui gli utenti tendono a raggrupparsi attorno a opinioni, credenze o ideologie sempre più estreme e divergenti, creando delle “bolle” in cui le opinioni del gruppo vengono rinforzate e mai messe in discussione. Il fenomeno può verificarsi anche in conseguenza di attività automatizzate di profilazione degli utenti che raggruppano gli utenti per finalità commerciali.
La disinformazione, quindi, non mira a creare dei convincimenti, piuttosto mira ad avvelenare il dibattito, a scoraggiarlo, renderlo inutile a causa di una inconciliabilità tra le parti.
È soprattutto per questo che le campagne di disinformazione sono maggiormente efficaci contro le società democratiche, poiché il dibattito pubblico è libero e le dinamiche politiche si basano sulla capacità di dialogo tra posizioni differenti. La compromissione di questi meccanismi e l’inconciliabilità delle posizioni è il massimo risultato ottenibile da una campagna di disinformazione. Le realtà autoritarie e quelle in cui vi è un pesante controllo del dibattito pubblico risultano meno permeabili dalle campagne disinformative online.

Una campagna di disinformazione deve quindi colpire la pubblica opinione, che va intesa come il sentimento prevalente all’interno di una comunità su determinati argomenti e che si forma attraverso l’interazione di diversi fattori, tra cui i media, le conversazioni interpersonali, le esperienze personali e l’influenza di leader d’opinione.
Per ottenere un risultato, l’autore di una campagna disinformativa online deve inserirsi all’interno di questi i meccanismi e veicolare i propri contenuti; e per farlo, l’autore non deve necessariamente possedere un’efficace rete di influenza online localizzata sul proprio bersaglio (ad esempio non serve avere una estesa rete di utenze o siti italiani per colpire l’Italia).
È possibile, infatti, utilizzare due tattiche che ti consentono di aggirare questo ostacolo tecnico. La prima è quella di sfruttare i meccanismi automatizzati dell’ambiente digitale che si vuole utilizzare (social network, chat, forum). In questi casi è necessaria una grande attenzione nella fabbricazione editoriale del contenuto (lunghezza dei contenuti, immagini, termini da utilizzare ecc) che va calibrato sulle caratteristiche premianti dei meccanismi automatici di viralità.
La seconda tattica è quella di sfruttare le capacità di diffusione di circuiti d’influenza già esistenti, coinvolgendoli nella propria campagna dietro dazione o inconsapevolmente.

I circuiti d’influenza
I circuiti di influenza sono costituiti da una rete virtuale di utenze, pagine media, chat, forum, siti d’informazione e in generale realtà online costruite attorno alla promozione di alcune idee o tematiche – spesso generaliste – le quali tendenzialmente favoriscono l’avversione verso un altro gruppo o altri gruppi.

La costituzione di realtà online omogenee è agevolata dai meccanismi automatizzati della maggior parte dei servizi internet che, per favorire la pubblicità online, sono predisposti a profilare e classificare gli utenti secondo gli interessi comuni. Inoltre, l’ostilità verso altri gruppi online è una delle migliori e più classiche strategie per cementare un gruppo sociale.
I circuiti d’influenza sono veri e propri network editoriali che seguono una trama e una narrazione condivisa e la cui organizzazione in rete può anche essere molto complessa. La struttura di questi insiemi di siti web, pagini e profili utenti è rappresentata da una rete di nodi, connessi tra loro e con compiti precisi e preimpostati: creare contenuti, rilanciare, rivisitare, commentare o semplicemente diffondere. L’organizzazione della rete può essere anche molto complessa, con regioni (insieme di nodi collegati tra loro) differenti deputate a promuovere tematiche specifiche e collegate fra loro attraverso poli principali.
Le persone che animano le reti, fornendo i contenuti, possono essere semplici utenze riferibili a persone reali, oppure potrebbero nemmeno esistere ed essere semplicemente identità virtuali che non corrispondono alle identità personali e che nascondono l’azione di una o più persone che controllano l’utenza. In questi casi, l’identità virtuale può essere utilizzata per impersonare una o più persone con ruoli diversi all’interno della rete: autore, fonte autorevole, fruitore di contenuti, follower e attivista.
Inoltre, autori, commentatori, collaboratori, creatori di contenuti online e reporter improvvisati possono facilmente divenire personalità e fonti autorevoli grazie ad un complesso sistema di citazioni e ripubblicazioni all’interno di altri nodi del circuito stesso.
Una volta costruito l’insieme virtuale, ogni nodo del circuito agisce con ruoli diversi per ottenere l’interazione con internauti e utenti che usufruiscono dei contenuti promossi dalla rete, magari anche inconsapevole dell’artificiosità dell’intero sistema.
Il valore di una rete d’influenza online è dato dalla sua capacità di coinvolgimento e propagazione tra gli utenti non parte del sistema. Anche in questo caso le reti sfruttano i meccanismi dei modelli di business della maggior parte dei servizi internet attuali che favoriscono i contenuti che generano alti volumi di traffico o che ingaggiano più utenti.
Questo non necessita di una narrazione semplicemente falsa, ma può essere costituito da elementi di verità oggettiva che però si prestano ad interpretazioni e considerazioni diverse, possibilmente polarizzanti. L’obiettivo generale di una campagna di disinformazione è quello di stimolare e creare una polarizzazione tra le community online cercando di trasmettere questo sentimento di avversione anche nell’opinione pubblica e nella società presa di mira.
Il contenuto disinformativo online è quindi tratta un oggetto multidimensionale, passibile di più interpretazioni, che viene utilizzato per due sostanziali scopi: “mobilitare” e “combattere”. Nel primo caso si intende la necessità di mobilitare “i propri” o coloro che hanno idealità, pensieri e sentimenti affini al contenuto disinformativo, mentre lo scopo bellicoso è quello di contrasto e opposizione alla comunità avversa alla propria.
I manipolatori di una campagna di disinformazione possono essere soggetti interni ed esterni alla communità online presa di mira e possono utilizzare delle reti d’influenza online, che non necessariamente sono direttamente da loro controllate. Queste reti condizionano gruppi di utenti reali inconsapevoli e sono costituite da un insieme definito di siti d’informazione, utenze e chat collegate e coordinate tra loro con finalità che possono variare da quelle politiche a quelle commerciali.
L’esistenza di queste realtà d’influenza può essere sfruttata dai gestori di una campagna disinformativa per alimentarne la pervasività. In questo meccanismo non è necessario che vi sia un accordo tra autori della campagna e gestori di una rete d’influenza, talvolta i secondi possono spontaneamente aderire per proprie finalità, essere ingannati dai primi o essere del tutto inconsapevoli della natura manipolata di un contenuto digitale.