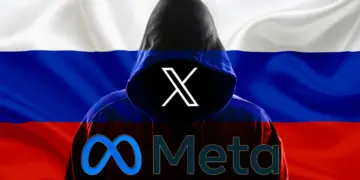Con il completamento delle operazioni militari iniziate il 19 settembre, da cui sono derivati la resa e il riconoscimento ufficiale dell’Armenia sulla sovranità azera nei territori del Nagorno Karabakh, si chiude definitivamente una questione iniziata un secolo fa.
La storia
Il Nagorno Karabakh è una regione del Caucaso meridionale a maggioranza armena e cristiana, che si trova all’interno dell’Azerbaijan, paese a maggioranza turcofona e musulmana. La travagliata storia del territorio e della minoranza che lo popola diventa oggetto di aspra disputa a seguito dello scioglimento dell’Impero zarista e con il fallimento dei tentativi di federalismo transcaucasico.
Successivamente passato sotto il controllo dell’Unione Sovietica, il Nagorno Karabakh ha goduto di ampia autonomia dalla RSS Azera, ma a seguito della dissoluzione dell’URSS, l’Oblast’ armeno si è proclamato indipendente ed è diventato il principale motivo di contesa tra Armenia e Azerbaijan. I due paesi si sono scontrati militarmente diverse volte nel ‘900 e almeno tre conflitti armati si sono verificati tra la fine dell’Unione Sovietica e oggi. Poiché la disputa non è mai stata risolta con un trattato di pace, tutti e tre gli scontri possono dirsi parte di un’unica lunga guerra.
La fine delle ostilità?
È molto probabile che l’agognato trattato di pace verrà siglato proprio a seguito di quest’ultima operazione militare e, nel migliore dei casi, risolverà uno dei principali fattori di destabilizzazione di tutta l’area; nel peggiore, sarà solo un passaggio per la crescita di nuove tensioni.
In ogni caso, l’unica cosa certa è che il trattato porrà condizioni dure a Yerevan. Pur non avendo partecipato direttamente agli scontri di settembre, l’Armenia è stata la grande sconfitta sia sul campo militare che in campo diplomatico. Per questo è probabile che il paese dovrà rinunciare non solo ad ogni vantaggio acquisito negli anni ’90, ma dovrà negoziare rinunciando a qualsiasi ambizione di potenza regionale e forse anche di più.
Le mosse della vittoria azera
Un altro elemento certo è che a partire dal 1° gennaio 2024 la Repubblica dell’Artsakh non esisterà più e la vittoria azera sarà totale. Gli armeni lasceranno probabilmente questi territori – al momento si parla di quasi 90 mila persone in fuga – e Ilham Aliyev, presidente azero e figlio di Gayar Aliyev (funzionario sovietico dell’epoca brezneviana, ufficiale del KGB ed ex presidente dell’Azerbaijan indipendente), verrà ricordato come colui che ha cancellato le onte degli anni ’90. Aliyev ha sapientemente costruito la propria vittoria: da quando è salito al potere ha saldato i propri legami con la Turchia, ha mantenuto ottimi rapporti con la Russia, si è avvicinato ad Israele comprando i suoi armamenti e ha legato a sé l’Occidente attraverso il gas.
Nel 2020 Baku ha sfruttato la propria opportunità per mettere il mondo e soprattutto Mosca – grande garante dell’Armenia – di fronte ad un fatto compiuto e ribaltare la situazione militare sul campo, fino a quel momento sfavorevole. In soli 44 giorni Baku ce l’ha fatta, in un modo tale per cui per riportare la situazione ad uno status ex ante sarebbe stato necessario un insensato intervento militare russo.
Per il successo militare azero sono stati decisivi gli armamenti forniti da Turchia e Israele, oltre che al cruciale addestramento tattico che ha annientato le difese armene fornito proprio da Tel Aviv. La disfatta armena all’epoca è stata pressoché totale e solo l’intervento diplomatico e militare russo è riuscito a congelare la situazione sul campo. Le cause principali sono state la mancanza di apparecchiature militari moderne e da carenze nell’efficienza delle tattiche militari.
Le trattative e le strategie dei due paesi
L’interposizione russa è valsa ad ottenere un cessate il fuoco e ha significato l’inizio di un difficile processo di pace che però non ha prodotto risultati tangibili e che si è definitivamente arenato questa primavera. Uno dei principali ostacoli è stata la riluttanza dell’Armenia a soddisfare le richieste di Baku, che includevano la creazione di collegamenti terrestri con l’enclave azera di Nakhchivan e la resa completa del Nagorno-Karabakh.
In quella fase, il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan ha contestualmente tentato di isolare diplomaticamente l’Azerbaijan, accusandolo di violare gli accordi del cessate il fuoco, e ha adottato una linea di deresponsabilizzazione della sconfitta militare, accusando la Russia e il CSTO di non aver fatto abbastanza. Ma questa strategia diplomatica è stata meno efficace di quella azera. Il tentativo di isolare l’Azerbaijan a livello internazionale è stato complicato dalla guerra in Ucraina e dalle forniture di gas che Baku fornisce all’Europa, mentre le denunce dei propri alleati hanno allontanato dal paese i principali garanti della sicurezza armena. Questa politica è stata aspramente criticata sia dagli oppositori del primo ministro, sia dai rappresentanti della diaspora armena americana, sia dai politici del Nagorno-Karabakh.
La posizione contraria al dialogo e una politica estera inconsistente hanno paradossalmente contribuito a legittimare la soluzione militare imposta dall’Azerbaijan, che ha guadagnato anche il consenso di potenze vicine come Russia e Iran. D’altronde sia Teheran che Mosca sono da tempo consapevoli che il Caucaso è ormai un condominio ex sovietico in cui è necessario accordarsi anche con i turchi.
Il fatto che l’esercito azero non abbia invaso l’Armenia per creare corridoi terrestri verso Nakhchivan, ma che si sia limitato ad occupare i restanti territori dell’Artsakh suggerisce l’esistenza di un accordo – per lo meno tra la Russia e Baku – che ha garantito l’inviolabilità dei confini dell’Armenia internazionalmente riconosciuti. In questo contesto, una politica armena più pragmatica, basata sul riconoscimento della propria inferiorità e su un maggiore dialogo con Mosca avrebbe potuto portare a risultati diversi, come delle solide garanzie per la sicurezza della popolazione armena del Nagorno-Karabakh.
L’Armenia non può lasciare la Russia
A questo punto, ciò che accadrà in futuro all’Armenia è incerto. Il contesto regionale suggerisce che sia improbabile che qualcuno degli attori caucasici abbia reale intenzione di continuare a ridiscutere su questioni di confini. Non è conveniente per nessuna potenza regionale aprire nuovamente la questione armena o azera rischiando la destabilizzazione della regione.
Dal punto di vista armeno, la posizione geografica del paese – circondato da popolazioni storicamente ostili e aliene – richiede la necessità di una garanzia di sicurezza esterna ed è più probabile che questa provenga dalla Russia. La leadership armena ha profondamente irritato il Cremlino, soprattutto per la decisione della di non partecipare a negoziati di pace come perdenti e di incolpare altri (Russia e CSTO) per la sconfitta del paese. Tuttavia, sembra improbabile che Mosca abbia intenzione di abbandonare l’area o che creda nell’ipotesi di un avvicinamento di Yerevan all’Occidente.

Infatti, l’Armenia dipende in quasi ogni settore dal suo rapporto con la Russia e inoltre ci sono dei fattori sostanziali che rendono quantomeno improbabile uno spostamento di Yerevan nel campo americano ed europeo:
- I legami storici e culturali tra la Russia e l’Armenia sono molto più radicati di quelli con qualsiasi altro paese;
- Non esiste nessun elemento di tipo economico che l’Armenia può offrire a Bruxelles o a Washington in cambio di garanzie di sicurezza;
- i principali nemici dell’Armenia sono l’Azerbaijan, partner indispensabile per gli europei, e la Turchia, membro della NATO.
In effetti, se si considera che per l’Armenia è obbligatorio ottenere una garanzia di sicurezza dalle possibili minacce esistenziali provenienti dai paesi turcofoni, il paventato distacco di Yerevan da Mosca e il suo conseguente avvicinamento agli USA e all’Europa sembra qualcosa di difficilmente realizzabile.
L’Armenia non si trova quindi al bivio e i suoi movimenti sono più spiegabili in ragione di un mero calcolo di politica interna. Diversamente, questa strategia sarebbe del tutto velleitaria ed in grado di raccogliere solo risposte altrettanto velleitarie. Lo sono i movimenti in questo senso della Francia che cerca di inserirsi in un quadrante a 3.432 km di distanza in chiave antiturca.
In ogni caso, il problema più imminente per gli armeni è il mantenimento della stabilità interna. Infatti, è difficile immaginare un intervento del CSTO in questo senso, almeno finché Pashinyan sarà al potere. Questa potrebbe essere la principale ragione per cui Pashinyan si dimostra assertivo e propenso ad avvicinarsi all’Occidente. Il passato di tumulti popolari – Nikol Pashinyan conosce bene, avendone usufruito da leader dell’opposizione – potrebbe aver convinto il primo ministro armeno che la propria sopravvivenza politica sia la miglior garanzia per la propria sopravvivenza fisica.