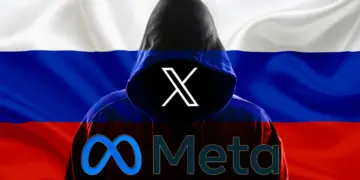Negli ultimi decenni, l’opera di Tucidide, La guerra del Peloponneso, è stata elevata quasi a “fondamento ideologico” della politica estera statunitense, attraverso interpretazioni spesso parziali e, in alcuni casi, distorte degli scritti dello storico greco. Ma come può un testo del V secolo a.C. influenzare le decisioni di una superpotenza contemporanea? La risposta risiede in una serie di riletture attualizzate, spesso forzatamente, di Tucidide da parte di influenti intellettuali e decisori politici statunitensi, utilizzate per giustificare strategie di politica estera interventiste e finalizzate a preservare l’egemonia globale degli Stati Uniti di fronte a potenze emergenti come la Cina: un approccio che, anche su scala ridotta e relativamente a conflitti di carattere regionale, può essere un importante spunto di riflessione, circa la tendenza ad un orientamento interventista ed al depotenziamento del dialogo diplomatico, dinamiche che appaiono sempre più ricorrenti nel contesto geopolitico contemporaneo.
La “dottrina Bush” dell’attacco preventivo
Nel corso degli ultimi decenni, molti studiosi hanno evidenziato le distorsioni e gli usi strumentali dell’opera di Tucidide, sottolineando come determinate interpretazioni abbiano alimentato una retorica di inevitabilità del conflitto. Un chiaro esempio di una visione semplificata e artificiosamente distorta della storia, utilizzata per giustificare politiche “interventiste”, è quello della cosiddetta nella “dottrina Bush” del 2002[1], con il concetto di “attacco preventivo” assurto a strumento atto a preservare la supremazia americana, giustificando così l’intervento in Afghanistan del 2001, prima, e la guerra in Iraq del 2003, poi.
L’attacco preventivo viene qui presentato come necessario per garantire la sicurezza degli Stati Uniti e dei suoi alleati, a fronte di una minaccia che, secondo le autorità americane, avrebbe potuto divenire concreta nel medio termine. Questa strategia di intervento preventivo ha contribuito significativamente a ridefinire le alleanze internazionali e ad accrescere un generale senso di sfiducia verso l’approccio degli Stati Uniti alla gestione dei rapporti internazionali, rafforzando una percezione del mondo come spazio anarchico e conflittuale, dove la guerra appare come un mezzo inevitabile per garantire la propria sicurezza e stabilità.
La strategia politica di Bush, vogliamo sottolineare, non è frutto di improvvisazione, ma ha radici profonde in teorie filosofiche complesse e in una rete di influenze intellettuali tutt’altro che estemporanee. Nel 1997 Donald Kagan, uno storico greco di Yale, contribuì a fondare il Project for the New American Century, un think tank che avrebbe profondamente influenzato la politica estera americana nei primi anni 2000, fornendo una base ideologica coerente per l’espansione del potere militare e il mantenimento dell’egemonia globale degli Stati Uniti. Kagan, insieme ad altri esponenti neoconservatori, vide in Tucidide una giustificazione storica per una politica di deterrenza e di uso esplicito della forza militare come mezzo per garantire la pace e la stabilità, sostenendo che la debolezza e la mancanza di aggressività fossero fatali per le potenze aspiranti al dominio. Secondo Kagan, Atene fallì nell’intento di imporre il proprio predominio perché non fu abbastanza aggressiva nell’esercitare il proprio potere militare, e questa lezione doveva essere applicata anche agli Stati Uniti per evitare un declino simile. La sua interpretazione, quindi, presentava il potere militare non solo come strumento di difesa, ma come elemento attivo di stabilizzazione e imposizione dell’ordine, legittimando così una politica estera espansiva e interventista.
Per Kagan, la storia non è una lezione di prudenza, ma piuttosto un manuale di strategie per garantire il dominio, e questa visione ha avuto un impatto significativo sulla formulazione delle politiche neoconservatrici. Le idee promosse da Kagan e dal Project for the New American Century hanno contribuito a creare un clima politico in cui l’uso della forza era non solo accettato, ma considerato necessario per preservare l’influenza globale americana, rendendo la guerra preventiva una scelta quasi obbligata in nome della sicurezza e della stabilità internazionale.
La “trappola di Tucidide”
Un altro concetto spesso abusato dello storiografo greco è quello della cosiddetta “trappola di Tucidide”, in riferimento ad una situazione in cui una potenza emergente minaccia di soppiantare una potenza dominante, creando una tensione che spesso sfocia nel conflitto armato.
Secondo Tucidide, che analizzò il conflitto, nel V secolo a.C., tra spartani e ateniesi, fu `«la crescita del potere ateniese e la paura che questa suscitò a Sparta» a rendere la guerra inevitabile, con la potenza dominante che si sentì minacciata dall’ascesa del rivale e agì preventivamente per preservare il proprio status. Il conflitto che ne seguì, la cosiddetta Guerra del Peloponneso, fu devastante per entrambe le parti e per l’intera civiltà greca: un esito tragico che sottolinea l’aspetto cruciale della Trappola di Tucidide, ossia che, spesso, il tentativo di prevenire un cambiamento nell’equilibrio di potere attraverso la guerra porta a conseguenze disastrose per tutti gli attori coinvolti.
Nel corso dei secoli, la teoria della trappola di Tucidide ha trovato innumerevoli applicazioni, dal declino dell’Impero Romano alla rivalità tra Gran Bretagna e Germania all’inizio del XX secolo, secondo uno schema di eventi che si è ripetuto con conseguenze significative. Oggi, con l’ascesa della Cina e il relativo declino dell’egemonia americana, molti osservatori temono che questa dinamica possa riproporsi con implicazioni globali senza precedenti.
L’interpretazione di Graham Allison
A onor del vero, il termine “trappola di Tucidide” è stato effettivamente coniato nel 2012 dal politologo statunitense Graham Allison, professore di relazioni internazionali ad Harvard. Secondo Allison, quando una potenza emergente, come la Cina, sfida una potenza dominante, come gli Stati Uniti, il risultato più probabile è la guerra. Questo paradigma, che descrive la tensione crescente tra potenze in trasformazione, è stato ripetutamente impiegato per spiegare l’ascesa della Cina e la risposta degli Stati Uniti, contribuendo a diffondere l’idea che – come nel passato – il conflitto tra le due superpotenze sia inevitabile. L’approccio di Allison riprede le osservazioni di Tucidide e si basa sull’interpretazione secondo cui Sparta, potenza dominante, e Atene, potenza emergente, si trovarono intrappolate in una dinamica di potere inevitabile, alimentata dalla paura reciproca: la potenza consolidata, temendo la perdita del proprio status, reagisce sempre con aggressività per mantenere il predominio, mentre la potenza emergente cerca di affermarsi, generando una spirale di tensione che rende il conflitto ineluttabile.
Bisogna notare, tuttavia, che l’adozione dogmatica della teoria della trappola di Tucidide come proposta da Allison rischia di alimentare una profezia “auto-avverante”, in cui l’idea della guerra inevitabile finisce per modellare il comportamento degli attori internazionali, portandoli ad accelerare il conflitto piuttosto che ad evitarlo: la semplificazione che emerge dalla teoria di Allison, infatti, non tiene conto di numerose variabili, come le interdipendenze economiche, i legami culturali e le capacità diplomatiche, che possono e dovrebbero essere utilizzati per scongiurare il confronto diretto. In questo senso, la narrativa della trappola di Tucidide rischia di legittimare un approccio fatalistico alle relazioni internazionali, scoraggiando gli sforzi diplomatici e le strategie di de-escalation che potrebbero effettivamente evitare il conflitto.
Il radicamento della dottrina nelle accademie militari americane
L’interpretazione interventista degli scritti di Tucidide non è fatto nuovo nella cultura americana: già negli anni ’70, l’opera dello storico greco è divenuta parte integrante del curriculum delle accademie militari statunitensi, grazie alla riforma del Naval War College di Newport promossa dal viceammiraglio Stansfield Turner. Una tale enfasi su Tucidide riflette, certamente, un interesse genuino per la storia antica, ma anche una tendenza a leggere il passato attraverso la lente delle esigenze strategiche contemporanee, con attitudine profondamente antistorica, poiché non si considerano gli eventi del passato per ciò che furono, ma per ciò che possono insegnare nel presente, spesso reinterpretandoli con l’obiettivo di giustificare ideologie e politiche moderne.
Tucidide, in realtà, non offre una giustificazione univoca per la guerra o una guida pragmatica per la gestione del potere imperiale; al contrario, presenta un’analisi profonda delle dinamiche umane, delle ambizioni e delle paure che conducono gli stati al conflitto. La sua narrazione è intrisa di un senso di tragedia, in cui la guerra è spesso il risultato di errori di calcolo, arroganza e incomprensione delle intenzioni altrui.
Il conflitto è realmente inevitabile?
Una lettura della storia obiettiva e scevra di preconcetti ci suggerisce che sono innumerevoli i casi, nel corso dei secoli, a testimoniare che il conflitto non è inevitabile.
Basti pensare, ad esempio, alla rivalità tra gli imperi spagnolo e portoghese nel XV e XVI secolo, periodo durante il quale, nonostante la competizione per il dominio dei mari e delle colonie, le due potenze riuscirono in gran parte a evitare un conflitto diretto, grazie anche alla mediazione papale e a una serie di trattati che divisero le sfere di influenza. Oppure al passaggio, relativamente pacifico, dell’egemonia globale dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti nel XX secolo, con le due nazioni che, nonostante alcuni episodi di tensione, condividevano valori culturali e politici che facilitarono una transizione senza conflitti armati diretti.
In tempi ancor più recenti, anche la Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica, sebbene con alcune peculiarità, può rappresentare un caso di studio di rilievo per l’interpretazione della trappola di Tucidide nel contesto moderno. Per quasi mezzo secolo, le due superpotenze si sono fronteggiate in una competizione globale che ha sfiorato più volte il conflitto diretto, con la crisi di Cuba del 1962 che, forse, rappresenta il momento in cui la “trappola” è stata più vicina a far scattare un’escalation globale. Un fattore cruciale che ha impedito lo scoppio di una guerra aperta tra USA e URSS è stata la deterrenza nucleare: la consapevolezza che un conflitto avrebbe potuto portare alla distruzione reciproca ha agito come un potente freno, introducendo una nuova variabile nell’equazione della trappola di Tucidide.
D’altro canto, anche se il fatto che la Guerra Fredda si sia conclusa senza un conflitto armato diretto tra le superpotenze viene spesso citato come un successo della diplomazia e della gestione delle crisi, non si possono tuttavia ignorare i costi umani ed economici del conflitto indiretto e della corsa agli armamenti, il che probabilmente impedisce di considerare il caso specifico come esempio di un ‘pieno’ successo.
Gli interessi geopolitici di Stati Uniti e Cina nell’era moderna
Gli Stati Uniti, emersi dalla Guerra Fredda come unica superpotenza globale, hanno goduto di una posizione di preminenza indiscussa per diversi decenni. Questa egemonia si è manifestata in ambito economico, militare, tecnologico e culturale.
Tuttavia, l’ascesa rapida e continua della Cina delle ultime decadi ha creato una situazione che molti osservatori paragonano, per l’appunto, alla classica trappola di Tucidide: la crescita economica cinese, accompagnata da un’ambiziosa modernizzazione militare e da progressi tecnologici significativi, sta mettendo fortemente in discussione l’egemonia americana in molti settori chiave, con un ulteriore aspetto distintivo della rivalità USA-Cina dato dal profondo divario ideologico tra i due paesi.
Aree di potenziale conflitto e possibili scenari
La rete di alleanze degli Stati Uniti in Asia, che include paesi come Giappone, Corea del Sud e Australia, è vista dalla Cina come un tentativo di contenimento, con questi sodalizi che potrebbero diventare motivo di frizione in caso di escalation delle tensioni.
Taiwan, poi, rappresenta forse il punto più delicato nelle relazioni USA-Cina. L’isola, che gode del sostegno americano ma è rivendicata dalla Cina come parte del suo territorio, rischia di diventare il fulcro di un confronto diretto tra le due potenze, benché ad oggi gli analisti siano divisi sulla probabilità che la rivalità tra le due superpotenze sfoci in un conflitto aperto; alcuni vedono, infatti, i segnali di una nuova Guerra Fredda, mentre altri sottolineano l’interdipendenza economica come un fattore che potrebbe prevenire l’escalation militare. L’emergere, poi, di altre eventuali potenze regionali e globali, come India, Brasile e Russia, complica ulteriormente qualsiasi previsione di lungo periodo.
Ad ogni modo, la diplomazia appare ancor’oggi lo strumento principale per navigare le acque turbolente della competizione tra le due grandi potenze mondiali: iniziative multilaterali, summit bilaterali e canali di comunicazione costanti sono essenziali per gestire le tensioni e prevenire malintesi, con la cooperazione su sfide transazionali e globali come il cambiamento climatico, le pandemie o la sicurezza cibernetica, che potrebbero offrire opportunità – se colte con lungimiranza – per costruire fiducia e interessi comuni.
Historia magistra vitae
La storia non è un mero repertorio di esempi da cui trarre lezioni applicabili al presente, ma rappresenta un campo di studio estremamente complesso e ricco di sfaccettature, che deve servire per comprendere le peculiarità e le specificità di ciascuna epoca storica: è lo stesso Tucidide, nelle sue Storie, ad ammonire il lettore su come arroganza e mancanza di comprensione della complessità possano condurre inevitabilmente al conflitto.
L’uso strumentale della storia per giustificare decisioni politiche attuali è un errore metodologico grave che trascura la natura contingente degli eventi storici, ignorando la necessità di un’analisi critica capace di riconoscere le profonde differenze che caratterizzano ogni contesto storico e politico.
Di contro, una corretta lettura degli eventi, con una visione non deterministica ma probabilistica della storia, può evitare di cadere in semplificazioni pericolose, rigide analogie ed erronee interpretazioni di presunte “costanti universali”, scongiurando la trappola intellettuale di una visione del mondo come luogo inevitabilmente votato al conflitto, in cui le potenze sono destinate a scontrarsi per sopravvivere.
Tucidide, se letto con attenzione, offre una lezione sull’importanza della prudenza, sulla comprensione delle dinamiche politiche e sulla complessità delle relazioni internazionali. Ignorare questi insegnamenti significa ridurre la ricchezza del suo pensiero e limitare la capacità di affrontare le sfide contemporanee con una prospettiva più articolata.
La storia non è predestinata a ripetersi, a meno che non la leggiamo in modo superficiale e la utilizziamo per giustificare scelte partitiche: la lezione principale di Tucidide non è quella di un mondo inevitabilmente in guerra, ma piuttosto quella di una storia fatta di decisioni, errori e opportunità di cambiamento. È nella capacità di analizzare criticamente il passato e di agire con consapevolezza che risiede il vero lascito dello storiografo greco per il nostro tempo.
Riferimenti
| ↑1 | per maggiori informazioni, si veda: https://en.wikipedia.org/wiki/Bush_Doctrine |
|---|