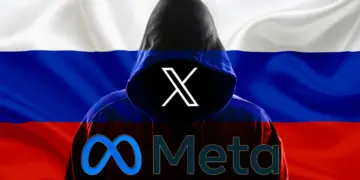Il 26 luglio 2023, il legittimo presidente del Niger, Mohamed Bazoum, è stato deposto da alcuni soldati della Guardia Presidenziale. Tentativi di rovesciare Bazoum erano già stati provati nel 2021, poco prima della sua proclamazione e nel marzo di quest’anno, quando il presidente era in visita ufficiale in Turchia.
Il contesto securitario dell’Africa Occidentale
Attualmente i poteri sono stati affidati ad una giunta, il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria, guidata da Abdourahamane Tchiani, uomo forte ai vertici della Guardia Presidenziale. È probabile che il coup d’état sia maturato in ambienti militari nigerini scontenti dell’operato di Bazoum il quale stava promuovendo un ricambio nei vertici dell’Esercito e guidato proprio dallo stesso Tchiani, prossimo ad essere dimissionato dal Presidente.
In linea generale, il golpe odierno rappresenta un durissimo colpo per la (agognata) pacificazione dell’Africa Occidentale, caratterizzata da una forte instabilità alimentata da conflitti sociali ed etnici, oltre che da una insorgenza decennale dei Tuareg del Sahel, la quale coinvolge direttamente le sigle terroristiche di matrice islamista radicale dell’area.
Tutti i principali paesi di questa porzione d’Africa, e in particolare i paesi confinanti con il Niger, sono attraversati da processi di disintegrazione che minano la loro sicurezza interna ed erodono quella dei paesi vicini. I gruppi insorgenti hanno sfruttato la porosità dei confini e la debolezza delle forze di sicurezza locali per espandere le proprie operazioni e per creare strutture e catene logistiche più estese e sicure. È proprio in conseguenza a ciò che il Niger è stato coinvolto nel fenomeno jihadista, quando, tra il 2015 e il 2017, i gruppi terroristici operanti nel Mali hanno invaso le regioni occidentali del paese nigerino.

Il golpe in Niger non costituisce una novità nell’area ormai nota come la Coup Belt, cioè quel gruppo di paesi dell’Africa Occidentale e del Sahel che sono stati teatro di tentati golpe (Sudan, Guinea Bissau, Gambia) o che sono retti da una leadership nata da un colpo di stato (Guinea, Mali, Burkina Faso). L’allargamento di questa fascia di paesi retti da militari rende inquiete tutte le nazioni africane – e in particolare quelli vicini alla Coup Belt perché timorose del rischio contagio. Il potere dei militari, infatti, potrebbe rappresentare una alternativa apparentemente forte rispetto alle giovani e fragili istituzioni nate dai difficili processi di democratizzazione degli stati africani.
L’Occidente in Niger
Il Niger paese tra i più poveri al mondo e che per quasi metà della sua estensione è desertico e inospitale rappresenta un crocevia importante per le rotte commerciali, energetiche e migratorie del continente. Inoltre, nel paese sono presenti missioni militari di Italia e Germania, mentre americani e francesi possiedono basi permanenti e contingenti militari consistenti e ben armati. Il considerevole dispositivo militare occidentale rispecchia l’importanza data a Niamey nella strategia securitaria dell’intera regione. La vicinanza dell’esercito nigerino alle forze di sicurezza francostatunitensi è sempre sembrata un buon antidoto contro l’inserimento nel paese del gruppo mercenario russo della Wagner. Queste circostanze rendono il golpe nigerino un fatto del tutto anomalo e atipico se consideriamo che sembra essere maturato in quegli ambienti del paese più vicini agli occidentali. Eppure, ciò che è accaduto il 26 luglio sembra aver colto impreparate tanto Washington quanto Parigi.
Il Ruolo della Russia
In linea generale, la Russia è da considerarsi un attore di primo piano nell’Africa Occidentale. Qui, al pari del resto del continente, Mosca opera attraverso la PMC Wagner e, per molti paesi africani, rappresenta un modello di sicurezza alternativo alla presenza americana o europea, sulla quale aleggia sempre l’accusa di neocolonialismo. L’insofferenza della popolazione e i fallimenti delle strategie securitarie occidentali hanno spesso funto da porta d’ingresso per le truppe della Russia, che oggi sono circa 30 mila in tutta l’Africa, di cui 3 mila tra il Mali e (probabilmente) il Burkina Faso, paesi confinanti con il Niger. Inoltre, in Africa, i russi hanno saputo raccogliere proficuamente una parte significativa dell’eredità sovietica. Questa non si limita solamente all’interconnessione tra alcuni stati del continente e l’industria bellica russa, ma abbraccia anche il fatto che molte delle attuali classi dirigenti africane si sono formate all’Università Lumuba di Mosca.
Per la Federazione russa, riuscire ad attirare all’interno della propria orbita il Niger potrebbe costituire un significativo vantaggio tattico nel vasto scenario di confronto con gli Stati Uniti e l’Unione Europea. Infatti, la rilevanza militare, economica, politica e umanitaria che gli occidentali attribuiscono a questo paese potrebbe essere sfruttata a loro sfavore, basti pensare alla possibilità di interrompere le esportazioni di uranio o al condizionamento dei flussi migratori, ma soprattutto alla possibilità di condizionare lo sviluppo del gasdotto Trans-Saharan-Gas Pipeline (TSGP) che dovrebbe collegare l’Europa alla Nigeria.
Gli indubbi possibili vantaggi non consentono però di individuare la Russia come l’ispiratrice del coup d’état nigerino. L’influenza sul Niger non è tale e nonostante le campagne di disinformazione digitali, le classi dirigenti e la popolazione del paese non hanno mostrato una considerevole insofferenza nei confronti di europei e americani. Non bisogna sopravvalutare le manifestazioni antifrancesi organizzate dai golpisti, con tanto di bandiere russe; non sono sufficienti a controbilanciare l’influenza determinante che gli Occidentali detengono in Niger, specialmente attraverso le relazioni con il mondo militare.

Le trattative
Quindi, l’ipotesi più probabile è che il colpo di Stato sia il risultato di motivazioni interne al Niger. Non necessariamente ne deriva che l’azione debba inevitabilmente assumere connotazioni antioccidentali. Questo apre invece un notevole spazio per trattative con i golpisti. In quest’ottica, i dichiarati tentativi di avvicinamenti con il Gruppo Wagner, il Mali e il Burkina Faso – quest’ultimi retti da giunte militari sostenute dai russi – sono probabilmente parte di una contrattazione in corso e, al tempo stesso, movimenti diplomatici e militari alternativi.
Mentre Francia, Stati Uniti e Russia rimangono in attesa o in movimento sotto traccia, lo stesso non si può dire dei numerosi attori regionali interessati alle sorti del Niger. La Comunità economica degli stati dell’Africa Occidentale o ECOWAS[1], ha minacciato un intervento militare diretto nel caso in cui la Giunta militare non decidesse di reinsediare il governo legittimamente eletto. La presidenza dell’organizzazione economica è di turno alla Nigeria, paese confinante con il Niger e certamente il più grande e influente di tutta la regione, il cui presidente Bona Tinubu aveva promesso all’inizio della presidenza che l’ECOWAS – CEDEAO si sarebbe mossa con durezza nei confronti di eventuali golpe. Immediatamente dopo il golpe nigerino, Tinubu si è mosso con grande assertività, contattando sia le forze golpiste che i principali alleati dell’organizzazione e, inoltre, ha interrotto i rifornimenti di corrente elettrica a Niamey per esercitare pressione.
A questi si oppongono con decisioni Guinea, Burkina Faso e Mali, che hanno dichiarato di sostenere la Giunta militare in Niger e hanno promesso il proprio sostegno militare nel caso in cui i paesi del CEDEAO decidessero di intervenire militarmente.
Scenari: l’intervento militare dell’ECOWAS-CEDEAO
Lo scenario dell’intervento militare esterno rappresenta, verosimilmente, la risoluzione peggiore per tutta l’area. Un conflitto diretto potrebbe avere un effetto domino in tutta la regione, stimolando e riaccendendo altri conflitti mai sopiti e situazioni interne rette da precari equilibri.
È improbabile che i paesi dell’ECOWAS, che per altro è un’organizzazione per la cooperazione economica, siano in grado di condurre efficacemente e con successo un’operazione militare coordinata e complessa come quella che sarebbe l’invasione del Niger. A maggior ragione se si considera che i paesi in grado di intervenire direttamente e concretamente sarebbero verosimilmente il Chad e soprattutto la Nigeria. Abuja possiede uno degli eserciti più grandi di tutta l’Africa, ma non possiede le capacità militari e la dovuta stabilità interna per poter sostenere uno sforzo militare di questo tipo. Ad oggi, tuttavia, la Nigeria non si è ancora esposta ufficialmente e solo pochi paesi della CE-DEAO hanno dichiarato di essere pronti a sostenere lo sforzo militare: Senegal, Costa D’Avorio, Benin e Sierra Leone.
Bisogna considerare la possibilità che l’intervento militare esterno dell’ECOWAS – CEDEAO possa causare anche l’intervento diretto di Burkina Faso, Mali e non si può escludere anche quello dell’Algeria. Il presidente algerino Tabboune ha già condannato qualsiasi ingerenza esterna in Niger e ha recentemente modificato la propria Costituzione rimuovendo il divieto al proprio esercito di operare all’estero. L’allargamento del conflitto e il coinvolgimento diretto di altri paesi dell’Africa Occidentale potrebbe inasprire il conflitto, causare una crisi umanitaria che investirebbe direttamente il Nord Africa e l’Europa e fungere da acceleratore per i processi di disintegrazione degli stati.
Scenari: mediazione
L’ipotesi di una mediazione internazionale che possa accontentare tutti gli attori portare a garanzie di un ripristino della democrazia, potrebbe essere trovato. In questa ipotesi, un ruolo significativo potrebbe essere svolto dall’Algeria. Algeri ha mantenuto una certa equidistanza rispetto a tutte le parti coinvolte, condannando il colpo di stato e le ipotesi di intervento militare. Inoltre, il paese nordafricano è fortemente interessato al ripristino della stabilità nel paese per ragioni politiche, securitarie ed economiche. In primo luogo, una mediazione consentirebbe all’Algeria di uscire da un cono d’ombra diplomatico e di agire come un attore regionale attivo. Inoltre, i quasi mille chilometri di confine con il Niger, all’interno di un’area investita dall’insorgenza jhiadista pone Algeri in una posizione di assoluto interesse rispetto alle sorti di Niamey. Infine, l’Algeria è il terminale del gasdotto TSGP che dovrebbe collegare l’Europa e la Nigeria e che passa proprio attraverso il Niger.
La possibilità che la soluzione alla questione nigerina possa trovare una soluzione pacifica potrebbe in ogni caso destabilizzare tutti i regimi democratici dell’area. Ad esempio, una soluzione frutto di una mediazione esterna all’ECOWAS – CEDEAO potrebbe far apparire l’organizzazione come debole e poco efficace nel contrastare l’ennesimo colpo di Stato di uno stato membro. Inoltre, è improbabile che una soluzione negoziata non comporti alcun vantaggio per i golpisti nigerini; di conseguenza, sorge il legittimo timore negli altri Stati africani che gli eventi di Niamey possano rappresentare un esempio per i propri militari infedeli.
Scenari: l’intervento militare occidentale
L’ampliamento della Coup Belt ad altri paesi dell’Africa Occidentale e soprattutto lo scarrellamento del Niger nell’area d’influenza russa, costituisce una seria minaccia anche per l’Unione Europea, la quale ha l’obiettivo di promuovere la democratizzazione dell’area e rischia di compromettere la realizzazione del gasdotto che, partendo dalla Nigeria, rappresenterebbe un’alternativa alle forniture di Putin per l’Europa. Pe questo, l’ipotesi di un intervento militare europeo o americano non si può completamente escludere, anche se appare improbabile. Bisogna considerare che un intervento diretto occidentale, potrebbe costituire un precedente che avrebbe gravi ripercussioni in tutto il Continente africano. Un’azione militare, infatti, potrebbe essere facilmente interpretata come manifestazione di politiche neocoloniali e diventare soggetta a una narrativa negativa anti-occidentale promossa sia da Pechino che da Mosca, oltre che dai gruppi di islamisti radicali. Un ulteriore considerazione negativa è data dal fatto che non è chiaro se il Niger sarebbe in grado di reggere un evento di questo tipo mantenendo la propria integrità territoriale e senza scivolare in una guerra civile o nel caos, peggiorando lo scenario. Va considerato che in questo frangente gli americani non hanno alcuna intenzione di aumentare la propria presenza militare nel continente africano, che considerano secondario rispetto all’area di contenimento della Cina (che per Washington parte da Taiwan). Diverso discorso vale per la Francia che considera primario lo scenario della Franceafrique, ma che non possiede il capitale politico e la credibilità sufficiente per compiere un’azione militare.
Riferimenti
| ↑1 | Ne fanno parte il Benin, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo, oltre ai sospesi Mali, Guinea, Burkina Faso e Niger. |
|---|