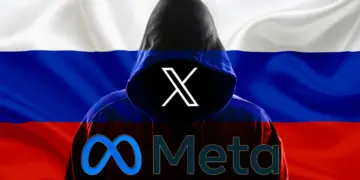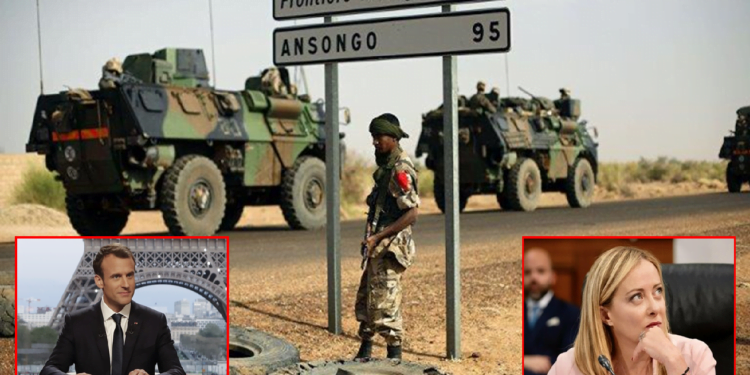Allo stato attuale tutti gli attori coinvolti continuano a intraprendere la scelta della trattativa diplomatica, ma non è chiaro quanto questa possa essere considerata una reale e concreta opzione e non un diversivo tra le parti per prepararsi alla guerra. Sia la Francia che i paesi membri dell’ECOWAS[1] potrebbero sfruttare il tempo delle negoziazioni per organizzare i propri dispositivi e preparare un’operazione militare.
Il quadro generale
La strategia del “prendere tempo” potrebbe essere anche stata adottata dai golpisti, che necessitano di consolidare il proprio controllo sul paese e organizzare eventuali difese. In questa fase è anche possibile che attori come l’Algeria, spinta dalla continua rivalità con il Marocco, possano proporsi come mediatori per risolvere l’impasse e assumere prestigio e un ruolo di maggiore rilievo in tutta l’area.
Nonostante il contesto in evoluzione, quanto accaduto nella notte del 26 luglio e nei giorni successivi a Niamey, ha evidenziato con chiarezza la grande distanza esistente tra due partner occidentali di primissimo piano: Francia e Italia.
L’Africa è storicamente una componente fondamentale della strategia di Roma e di Parigi, le quali fin dall’800 si sono trovate su fronti opposti, in una rivalità quasi continua: dallo schiaffo di Tunisi, fino alla guerra civile libica, passando per la guerra d’indipendenza algerina.
Con la fine dell’era Merkel, il cambio di strategia statunitense e gli stravolgimenti conseguenti, Parigi e Roma si sono riavvicinate per necessità. Al disimpegno politico e militare degli USA ha corrisposto un invito alle potenze regionali del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell’Africa, a farsi carico del controllo e della sicurezza dei loro spazi di interesse.
All’inizio di questa nuova fase, i due paesi europei non hanno immediatamente compreso il cambiamento e sono stati colti di sorpresa dall’assertività di altri attori regionali come la Turchia.
Una sconfitta per la Francia?
La Francia sembrerebbe il vero grande sconfitto della crisi nigerina, indipendentemente da come si evolveranno le cose. Per Parigi quanto accaduto a Niamey è l’ennesimo insuccesso delle proprie forze di sicurezza e di intelligence, oltre che della propria strategia politica nell’intera area. L’idea di poter creare uno spazio d’influenza francese, la «Françafrique», in una vasta porzione del continente africano è fallita.
Un così vasto programma si è dimostrato poco più che un’ambizione velleitaria e insostenibile, soprattutto per la presenza concorrente di attori globali e regionali come Russia, Cina, Turchia, Arabia Saudita e Qatar. D’altronde, questa idea di Françafrique si reggeva quasi esclusivamente su obiettivi securitari – lotta contro l’Isis, stabilizzazione dei conflitti separatisti e pacificazione etnica – che, nonostante il grande sforzo militare francese, non sono mai stati raggiunti compiutamente.

Inoltre bisogna considerare che la presenza francese non gode di particolare simpatia tra la popolazione in tutta l’area delle ex colonie, anche se non è del tutto esatto sostenere che le popolazioni locali siano animate da un sentimento antifrancese in senso lato. Il malcontento verso la ex madrepatria trova sì radici storiche, ma si consolida soprattutto con il fallimento nel raggiungimento delle promesse sicuritarie e nella discutibile gestione delle relazioni bilaterali tra paesi.
Un nuovo approccio strategico
I fallimenti africani, la fine dell’era Merkel (e quindi della comunione di intenti Parigi-Berlino), la nuova congiuntura sociale, economica e storica del paese, dell’Europa e del mondo, ha spinto la Francia verso un nuovo tipo di strategia: l’approccio generale è quello di costituire delle partnership con le potenze di media grandezza cedendo loro un po’ di spazio in cambio di sostegno e collaborazione. Si tratta di un cambiamento significativo per la Francia, che non rinuncia alla propria grandeur, ma che realisticamente ridimensiona le proprie ambizioni di sorreggere un grande piano post-imperiale.
Il paese transalpino quindi mira a diversificare le proprie relazioni internazionali per non dipendere più da singole relazioni bilaterali con le grandi potenze cercando una conciliazione di interessi opposti e sfruttare il potenziale interesse dei nuovi partner a compartecipare ad una strategia comune.
In Unione Europea, questo si traduce nel tentativo di uscire da un rapporto esclusivo con la Germania – in piena fase post-Merkel – e coinvolgere altri paesi dell’Unione per superare lo stallo che impedisce una maggiore integrazione politica ed economica a livello continentale.
Nel progetto di Parigi, l’Unione Europea deve assumere maggiore efficacia come attore globale per divenire uno strumento da utilizzare. Abbandonate le velleità indipendentiste all’interno del contesto Nato, la Francia cerca di guadagnare maggiore peso, rafforzando il suo ruolo come leader dei paesi continentali. La collaborazione con nuovi partner può anche contribuire all’incremento della capacità militare della Francia e al suo impegno nella gestione delle crisi globali.
L’Africa è un altro ambito in cui la Francia cerca di stabilire nuove partnership. La Francia ha interessi storici ed economici significativi nel continente africano e cerca di rafforzare la sua presenza e la sua influenza. Il coinvolgimento di nuovi partner può sostenere questi sforzi e migliorare la cooperazione nella gestione delle sfide regionali, come il terrorismo, la sicurezza e lo sviluppo.
In definitiva, la strategia della Francia è quella di cercare nuove partnership con potenze di media grandezza per aumentare la propria influenza e sostenere meglio i propri interessi in vari quadranti come l’Unione Europea, la Nato e l’Africa.
Le relazioni con l’Italia
Una simile strategia rappresenta un notevole cambio di rotta nelle gestione dei rapporti internazionali da parte di Parigi, che si rende particolarmente evidente analizzando la recente evoluzione dei rapporti con i cugini d’oltralpe; contrariamente a quanto accaduto durante la stagione dell’asse Francia-Germania, quella con l’Italia sembra adesso essere una partnership naturalmente conseguente e funzionale, utile sia in ambito europeo sia nella gestione dei problemi in Africa e in misura minore in ambito NATO.
Per questo, negli ultimi anni Parigi ha cercato con sempre maggiore insistenza un dialogo diretto con Roma, ottenendo dei discreti successi. Ad esempio, è stato grazie alla comunione di intenti tra Roma e Parigi che i due paesi hanno potuto imporre a Berlino un cambiamento di linea economica dell’Unione Europea durante la crisi Covid. Non solo: l’Italia è stata coinvolta direttamente nelle operazioni di sicurezza in Africa, come testimoniato dalla partecipazione alla missione in Niger. Infine, c’è la sigla del Trattato del Quirinale, che rappresenta l’intento di entrambe le parti di cristallizzare la nuova realtà collaborativa.
Tuttavia, l’approccio sinergico tra i due paesi latini sembrerebbe oggi avere subito una brusca battuta d’arresto, dovuta ad un evidente cambio di strategia avvenuto in campo italiano.
L’approccio italiano
Attualmente, l’Italia sembra aver orientato la propria postura su una posizione di aperta contrapposizione nei confronti di Parigi. L’attuale esecutivo sembra propenso ad una vera e propria “nuova fase politica”, con l’adozione di una linea che riveda drasticamente alcune posizioni del recente passato. Tra queste, la storica vicinanza a Mosca di alcune componenti di governo ma anche le più recenti intese con Pechino.
Il problema di una strategia di lungo periodo
Negli ultimi anni, se nel mondo si sono verificati sconvolgenti e incredibili stravolgimenti, è parsa tuttavia evidente la poca incisività della politica estera dell’Italia, che non ha saputo cogliere i cambiamenti in atto e si è scoperta in netta difficoltà nella gestione di tutti i dossier di proprio interesse.
In affanno nel disegnare una propria moderna strategia, l’Italia non sembra essersi mai ripresa dall’infarto libico ed è sempre sembrata troppo assorbita dai propri problemi interni per avere un approccio coerente in ambito internazionale o che non fosse totalmente episodico. Spesso ha dato l’impressione di farsi trascinare dagli eventi e questa postura ha portato l’Italia diventare oggetto – come altri paesi europei – di appetiti e interessi predatori altrui, subendo l’influenza di potenze meglio attrezzate – certamente favorite, in tal senso, dalla maggiore stabilità politica di forme democratiche incompiute – e con strategie di lungo periodo meglio definite, quali Cina e, parzialmente, Russia pre-conflitto.
Il Trattato del Quirinale
È in questo confuso contesto che è maturato il Trattato del Quirinale, un progetto immaginato dai governi italiano e francese nel 2018 e fortemente sostenuto dai due Capi dello Stato. Al di là dei giudizi di merito sul testo, è fuori di ogni dubbio che il Trattato, che stabilisce una collaborazione strutturata con la Francia, ha rappresentato comunque un tentativo di “riqualificazione” della posizione strategica italiano.
Posizione che però sembra essere stata nuovamente messa in discussione dall’attuale esecutivo, che in più occasioni ha dato dimostrazione di voler riprendere lo storico corso della rivalità con la Francia. Infatti, l’attuale Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni aveva espresso già nel corso delle precedenti legislature più di una perplessità sulla firma del Trattato del Quirinale, affermando che era necessario valutare attentamente gli interessi nazionali prima di impegnarsi in una collaborazione così stretta con la Francia.

Tuttavia, è importante sottolineare che l’evoluzione delle relazioni tra Italia e Francia è complessa e influenzata da molteplici fattori: certamente pesa il fatto che i vertici politici italiano e francese si trovino su posizioni diametralmente opposte sia dal punto di vista ideologico, sia perché impegnati in una campagna elettorale europea che vede le due leadership avversarie, sia per una buona dose di antipatia personale tra Meloni e Macron.
Negli ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi che hanno evidenziato i difficili rapporti tra l’Eliseo e Palazzo Chigi, oltre alle polemiche politiche tra maggioranze di governo e la questione migratoria – che è divenuta una priorità di politica interna per entrambi – anche le diverse posizioni assunte su dossier economici e securitari.
A tal proposito il golpe nigerino sembra aver giocato un ruolo significativo, soprattutto per come potrebbe essere interpretato a Parigi il comportamento italiano. Il collocamento dell’Italia dopo il colpo di mano in Niger è al momento non del tutto definito: la principale preoccupazione italiana sembrerebbe quella di mantenere l’integrità del paese africano e ciò porterebbe ad operare con un certo attendismo (la convinzione è che sia preferibile al momento mantenere un atteggiamento cauto).
Il Belpaese, tuttavia, si è mosso anche in modo autonomo rispetto a Parigi, dismettendo immediatamente parte del proprio dispositivo militare e assicurandosi la “non ostilità” dei golpisti. Inoltre, Roma ha ammonito sia l’ECOWAS, sia la Francia, contro una possibile azione militare sostenendo le ipotesi di trattativa e dialogo con la giunta militare nigerina.
Relazione necessaria
In conclusione, allo stato attuale il Niger rappresenta un evidente passo indietro nei tentativi di armonizzazione delle politiche estere di Francia e Italia. Tuttavia questa è probabile rappresenti l’unica strada per entrambi nel lungo periodo, poiché nessuno dei due possiede i mezzi per cambiare le politiche europee, risolvere le crisi internazionali e colmare gli spazi di manovra geopolitica da solo.
La collaborazione tra i due paesi cugini potrebbe invece portare enormi benefici ad entrambi – sia in ambito europeo, sia per la tutela dei propri interessi nel Mediterraneo e in Africa – e superare l’impasse dando attuazione al Trattato bilaterale tra i due paesi, potrebbe essere un primo passo.
Riferimenti
| ↑1 | L’Economic Community of West African States (Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale), è un’organizzazione regionale nata nel maggio del 1975, in seguito al Trattato di Lagos e formata da 15 paesi afferenti all’area. L’obiettivo principale e ultimo della Comunità è quello di promuovere, attraverso la creazione di un unico blocco commerciale, l’integrazione tra i membri e di raggiungere l’autosufficienza economica degli stati che ne fanno parte. |
|---|